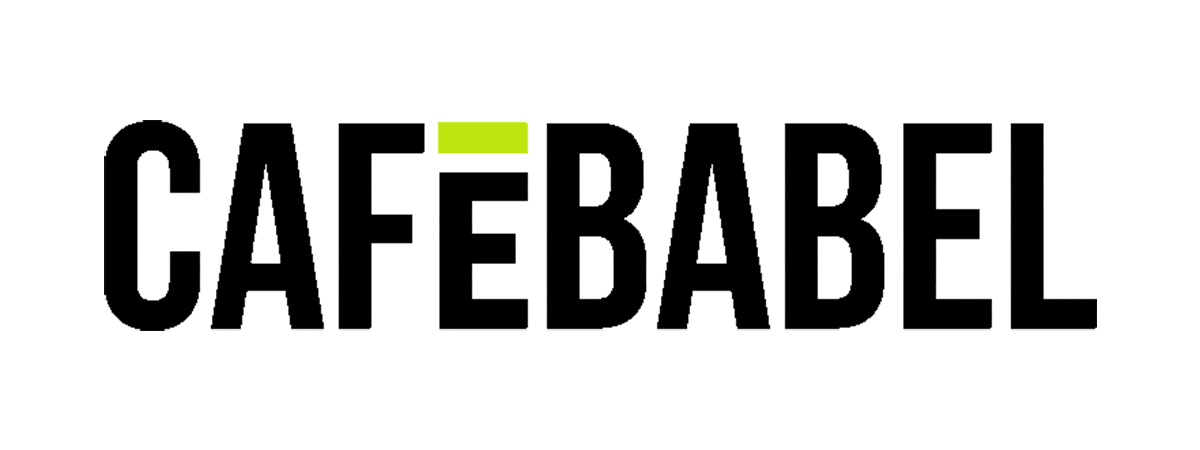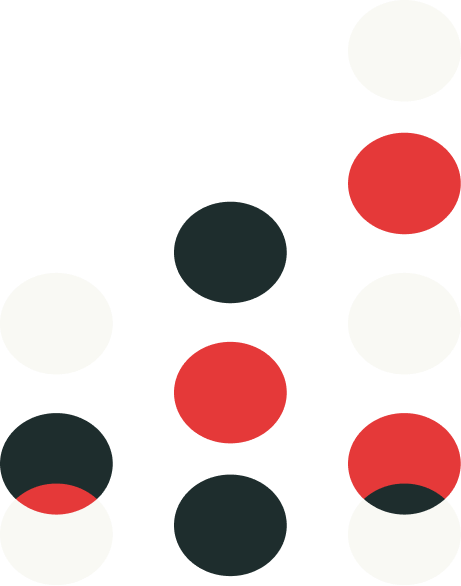Zamora, Spagna: non è un paese per giovani donne
Published on
Translation by:
Giulia BernasconiArticle in it
La provincia di Zamora (Spagna) rischia di diventare un deserto demografico. In particolare, trovare donne sotto ai quarant'anni attive nell'agricoltura è una sfida. Cosa fa lo Stato spagnolo per fermare il trend? Poco. Ecco le storie, battaglie e i sogni di coloro che, senza saperlo, hanno iniziato una rivoluzione silenziosa, in una terra abitata tradizionalmente da uomini.
«Non voglio passare tutta la mia vita a Zamora. È diventata troppo piccola per noi», risponde con voce ferma Emma, dopo aver immaginato un futuro nella sua provincia natale. Emma ha 21 anni ed è originaria di Villadeciervos, una cittadina di 418 anime secondo i dati dell'Istituto nazionale delle statistiche spagnolo (INE). Da qualche anno, per lavoro, vive con la famiglia a Zamora, la capitale dell’omonima provincia. Un cambiamento che tuttavia non ha avuto nulla di traumatico: «Non vorrei tornare a Villadeciervos nemmeno d’estate. Al limite, potrei farlo per un paio di giorni e, in caso, con una macchina a disposizione», racconta, seduta ai tavolini del ristorante del porto turistico di Ricobayo, un villaggio che conta meno di cento abitanti e che attira molte persone nel periodo estivo. È qui che, durante l’alta stagione, Emma lavora come cameriera insieme ad altre ragazze. Emma e le sue colleghe hanno tutte meno di 25 anni: un dettaglio che potrebbe passare inosservato, se non fosse che Zamora ha l'indice di vecchiaia più elevato di tutta la Spagna. Insomma, in questa provincia, per i giovani spagnoli, è difficile anche soltanto socializzare.
Benvenuti nella “Lapponia spagnola”
La provincia di Zamora è stata recentemente paragonata alla "Lapponia del sud", o denominata anche "Lapponia spagnola" - l’espressione indica in realtà una regione più ampia composta dalle province di Guadalajara, Soria, Teruel, Cuenca e una parte di Valencia. Tutto ciò avviene per un buon motivo: in questa zona, la densità demografica è inferiore a otto abitanti per chilometro quadrato. Insomma, stiamo parlando di un vero e proprio deserto demografico. A causarlo, l'invecchiamento della popolazione, la scarsa immigrazione e l'emigrazione di giovani, soprattutto di donne. Del resto, su scala globale, secondo l'ONU, nel 2050, due terzi della popolazione mondiale sarà concentrata nelle aree urbane: Zamora sembra semplicemente anticipare il trend.
«O te ne vai, o rimani e passi il resto dei tuoi giorni amareggiata»
La “macchina” citata da Emma, è una di quelle parole che fanno parte della maggior parte delle conversazioni che si possono intraprendere con i cittadini di questa regione. Nelle zone rurali, vivere la quotidianità senza un veicolo è complicato. Le grandi distanze abbinate alla scarsa densità demografica determinano l’insostenibilità dei trasporti pubblici per andare al lavoro, per studiare o per visitare il medico. Così, ogni weekend, Emma e la sua amica Andrea prendono in prestito la macchina della madre della prima per percorrere i venticinque chilometri che separano le città di Zamora, dove vivono e studiano, da Ricobayo. Entrambe hanno alle spalle una formazione da tecnico di laboratorio. Emma ha studiato infermieristica a Zamora (Università di Salamanca), grazie a uno dei dieci corsi che possono essere seguiti al campus. In realtà, la scelta di restare a studiare in zona non va per la maggiore tra i giovani: una buona parte dei coetanei delle due ragazze si sono trasferiti nelle grandi città, a Madrid o a Salamanca. Ma Emma e Andrea guardano con occhio critico il fatto che, per continuare a studiare, si debba, prima o poi, fare le valigie: «A Zamora, nel settore sanitario, non ci sono opportunità. In quello alberghiero sì, ma non si tratta di un percorso adatto a laureati come noi», dichiara Andrea. Il suo pessimismo aumenta col susseguirsi delle domande: «Non c'è proprio nulla da fare qui. Di regola, una volta concluso il percorso scolastico, ti sposti in un’altra città. Del resto, o te ne vai, o rimani e passi il resto dei tuoi giorni amareggiata [...] Al massimo, lavori nel settore alberghiero o diventi insegnante», spiega.

Sono difficoltà che vengono aggravate dal fatto di essere donne: «La mentalità retrograda e maschilista che aleggia tra le persone mi sorprende ancora, soprattutto in un’epoca come la nostra, in cui il femminismo è al suo apice. Posso comprendere che, in passato, i nostri genitori e nonni accettassero la cultura dominante. Ma oggi, con la quantità di risorse che abbiamo a disposizione per farci un’idea in maniera autonoma ... Il problema deriva dal tipo di educazione che riceviamo», spiega Emma. Parlando di inserimento nel mondo del lavoro, le donne incontrano più difficoltà della controparte maschile. Molti impieghi sono ancora considerati “da uomini”, soprattutto nelle zone rurali: «Certo, nessuno ti dirà che non puoi occuparti del bestiame, ma se poi lo fai veramente, diventi automaticamente “diversa”. E le persone ti parlano male alle spalle».
La dinamica descritta da Emma non è casuale. E dipende anche dal fatto che le zone rurali, al contrario di quelle urbane, sono caratterizzate da un chiaro squilibrio demografico: la bilancia pende chiaramente a favore degli uomini. Per esempio, se si guarda alla popolazione di Zamora che vive in campagna (si tratta della maggioranza) e, dunque, fatta eccezione per il capoluogo e le cittadine di Benavente (18.095 abitanti) e Toro (8.789 persone), si contano 94 donne ogni 100 uomini. A livello nazionale, il rapporto è invece di 104 donne ogni 100 uomini. Il disallineamento è ancor più visibile nella fascia d'età tra i 20 ai 29 anni: secondo i dati dell'INE (gennaio 2017), nelle aree rurali di Zamora, ci sono 88 ragazze ogni 100 ragazzi.
La virilizzazione rurale
Quello dello squilibrio demografico e della conseguente difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro delle donne sono problemi tipici delle aree rurali. La professoressa Rosario Sampedro, delll'Università di Valladolid, ha studiato il fenomeno nel dettaglio. Nelle sue ricerche parla di "virilizzazione rurale". Per molti anni questa preponderanza mascolina è stata spiegata con due trend: la maggiore propensione delle donne a vivere in città e la prevalenza di impieghi considerati “da uomini” in campagna. Allo stesso tempo, si tratta anche del risultato di una cultura ben precisa: se i bambini vengono educati per occuparsi del bestiame o per lavorare i campi in vista di un'eredità futura, le bambine ricevono un'istruzione non necessariamente legata alle attività agricole.
Anche se esistono prove a conferma di questo tipo di teorie, è comunque visibile una controtendenza che vede le donne, anche meno istruite, fuggire dal loro “ruolo” tradizionale, alla ricerca di un impiego. Nella maggioranza dei casi, le pratiche che ancorano le donne alle aree rurali passano per il lavoro autonomo, per esempio: la creazione di un’impresa, la gestione dell'azienda di famiglia o la partecipazione attiva in settori tradizionalmente maschili, come l'agricoltura. «Ci sono persone che adorerebbero vivere in un paese e che non lo fanno per mancanza di lavoro, alloggio, istruzione e sanità», spiega Rosario. E aggiunge: «Se ammettiamo che è positivo che i villaggi non scompaiano, credo che dovremmo promuovere misure attive per il lavoro nelle aree rurali. In questo senso, la digitalizzazione può giocare un ruolo strategico. Bisogna inoltre essere coscienti del fatto che la chiusura di una scuola o di una struttura sanitaria in un piccolo centro nel nome dell’efficienza economica, può costar caro a medio e lungo termine, perché finisce per allontanare la popolazione».
Un esempio concreto di politiche attive per sostenere le aree rurali è data dalla legge spagnola sulla comproprietà del 2011. L’approvazione della normativa è stata una tappa importante per dare nuova visibilità alle agricoltrici che hanno lavorato nei campi con i loro mariti per molti anni, e che, nonostante ciò, non avevano diritti o non godevano di retribuzioni adeguate. La legge ha finalmente permesso alle donne di affermarsi con relativa facilità come proprietarie di terreni agricoli. Al momento della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, la legge è stata descritta come una “manna dal cielo” per le aree rurali, un'occasione unica per evitare che le campagne non rimanessero più un universo maschile. Ma a otto anni di distanza, in Castilla, la legge non piace a tutti. Le associazioni femministe della regione chiedono misure aggiuntive in favore dell’uguaglianza tra uomo e donna. Anche il ministro dell'Agricoltura ha ammesso che la legge non ha avuto gli effetti desiderati. Infatti, secondo i dati ufficiali del Ministero, poco più di 400 aziende sono state registrate alla luce della nuova normativa.
C’è poi una seconda misura che va di pari passo con la prima. Ovvero, l’istituzione di una tassazione forfettaria per imprenditori indipendenti, pensata per mettere in risalto l’attività lavorativa delle donne in agricoltura. Per due anni, i nuovi lavoratori autonomi residenti in comuni con meno di 5.000 abitanti sono chiamati a versare cinquanta euro al mese nelle casse dello Stato. Per le donne sotto ai 34 anni, la misura si estende a tre anni ed è abbinata a una serie di sconti fiscali. Quali critiche sono state mosse all’iniziativa? Le giovani donne non possono beneficiare dei vantaggi qualora abbiano avuto lo status di autonomo in precedenza (un fatto piuttosto comune nel settore agricolo). Il risultato è che, dopo tre anni, le lavoratrici si ritrovano nuovamente isolate ad affrontare le difficoltà del contesto socio-culturale in cui vivono: «Ho la fortuna di non essermi mai iscritta come autonoma precedentemente. Ma conosco una ragazza che alleva pollame bio e che aveva aperto un bar precedentemente. Oggi non riceve alcun aiuto dallo Stato», racconta Rocío.
«E tu? Verresti qui ad allevare pecore 365 giorni l'anno?»
Rocío ci accoglie all'entrata della sua stalla, poco lontano da Prado, un paesino di 55 abitanti. Tutt'intorno, vasti terreni si estendono a perdita d'occhio. Oggi Rocío ha 37 anni, è sposata ed è madre di due bambini. Originaria di Zamora, si è a lungo domandata dove vivere, fino a quando non ha deciso di stabilirsi nella sua terra natale in via definitiva. «Per molti genitori, il fatto che i figli rimangano qui rappresenta uno stigma. Si tratta di un sentimento che viene inculcato dalla propria famiglia», afferma in maniera serena, senza un briciolo di rabbia. È sabato e c’è del pane in tavola, ma Rocío non si preoccupa di interrompere la sua routine per un'intervista. Intanto, suo padre, 69, sbuccia l'aglio in cucina. Il marito assiste a una fiera agricola nel nord della Spagna e i suoi bambini sono a casa della nonna. «Non so perché il Governo non incoraggi le persone a rimanere in questi luoghi, o meglio: credo che vogliano che diventi un deserto per le grandi aziende agricole», spiega. È una sensazione molto diffusa tra gli abitanti dei comuni delle aree rurali spagnole: la politica dà le spalle alle necessità dei cittadini per concentrarsi sulle grandi città, in cui risiede la maggioranza dell'elettorato. Perché darsi la pena di rendere dinamici dei paesi quando, tra qualche anno, vivremo tutti in un numero limitato di metropoli? «Il Governo dice di fare tutto il possibile per contrastare lo spopolamento. Ma che cosa fanno veramente? Non ho visto muovere un dito. I giovani preferiscono andare in città, lavorare come guardie di sicurezza e arrivare agli 800 euro al mese, invece di costruire qualcosa di solido qui».

In questo senso, come Emma e Andrea, anche Rocío rappresenta un’eccezione. Un giorno, dopo aver consacrato la sua giovinezza alla pallacanestro, una nuova opportunità la invita a lasciare la città. «Quando uscivo da scuola a Villalpando (1.519 persone), mi aspettava un'ora di bus per andare a Zamora, poi facevo i compiti, mi allenavo dalle otto alle dieci e un taxi mi riportava a casa, perché mio padre non aveva tempo per venirmi a prendere». Poi, a 18 anni, Rocío si conquista l'opportunità di continuare a giocare altrove: Cáceres, Ourense o Bilbao. Sceglie di stabilirsi nei Paesi Baschi insieme al suo ragazzo (oggi marito, anche lui originario di Zamora) che trova lavoro in un servizio clienti di una grande impresa di energia elettrica. Ma quando quest’ultimo perde il lavoro e il padre di Rocío si avvicina alla pensione, ecco il cambio di direzione «Perché non tornare al villaggio e costruire qualcosa?».
«Ho vissuto in città, ma la libertà che ho qui non l'ho mai avuta altrove»
Ed è quello che è accaduto in seguito. Rocío e il marito hanno avviato una fattoria biologica che commercia prodotti come l'aglio o i ceci. «Nessuno capiva perché avessimo lasciato la città e i nostri lavori per andare a coltivare i campi [...] Per i nostri conoscenti tornare a Zamora era una perdita di prestigio, anche se in città non facevamo una grande vita». Il risultato? «Oggi posso dire che ho vissuto in una metropoli; ma la libertà che ho qui, laggiù non l'ho mai percepita», afferma categorica Rocío, senza tuttavia perdere la il senso della realtà. La sua determinazione a cambiare le cose in un ambiente tradizionalmente dominato da uomini le è valsa molte critiche: «Quando mi vedono con il trattore si mettono ancora le mani tra i capelli», racconta, mentre si lascia andare a una risata. Rocío è tra le donne che hanno potuto godere della legge sulla comproprietà, grazie alla quale è proprietaria del 50% dell'azienda. «A Zamora, le ragazze si dedicano principalmente all'aiuto domestico, ma molte famiglie hanno in dote un gregge di pecore. Le giovani potrebbero occuparsene; non lo fanno e vanno a lavorare in una residenza, per esempio».
Per le ragazze che vorrebbero dedicarsi ad altri settori, o proseguire gli studi, la via d'uscita da questa realtà è legata al conseguimento della maggiore età. A quel punto possono aspirare a realizzare quello che vogliono. «Anche per questo motivo, stiamo costruendo una casa tutta su un piano: i nostri figli se ne andranno quando avranno diciott'anni. Diamo per scontato che faranno le valigie, perché è quello che è successo a tutti noi».
Nelle risposte di Rocío si percepisce una critica al conformismo di una regione che sembra aver accettato il suo destino e che sembra non aver più la forza di lottare per il cambiamento. «In Francia, quando gli agricoltori decidono di non vendere latte per ragioni economiche, lo fanno. Per di più, bloccano anche quello di provenienza straniera. Qui, invece, non succede nulla. La mentalità a Tierra de Campos e in Castilla, più in generale, consiste nel dire: “Non importa quello che facciamo, perché intanto non cambierà nulla”. Tutto viene accettato acriticamente, anche in politica. Io e mio marito partecipiamo ancora alle manifestazioni, ma siamo quattro gatti ormai. Lo facciamo perché abbiamo coscienza del problema che viviamo, ma si finisce sempre con il pensare che sia meglio smetterla di lavorare per una causa comune che nessuno sostiene. È un sentimento molto comune qui. D’altronde, i ragazzi della zona finiscono in prima pagina solo quando bruciano quattro ruote di una macchina».
Quando parla della sua vita e della quotidianità, Rocío trasmette una sensazione di normalità assoluta. Non ha bisogno di mentire o esagerare. Allo stesso tempo, è forte dell’esperienza di aver vissuto sia nel mondo rurale che in quello urbano: «Devi amare la dimensione della campagna, altrimenti, vivere qui diventa una condanna a morte». Fa una pausa, si morde il labbro, ci guarda e chiede: «E voi? Verreste qui ad allevare pecore 365 giorni l'anno?».
Un viaggio di sola andata
Da Nord a Sud, il confine tra *Portogallo e Spagna conta più di mille chilometri. È talmente stretto da essere soprannominato "La Raya" ("La linea", "A raia" in galiziano e portoghese). Una fetta di terra fatta di fauna e tradizioni comuni, nati da secoli di coesistenza. Proprio qui, a Zamora, nel 1433, fu sancita la pace tra le due nazioni e riconosciuta la sovranità portoghese. Oggi, il Trattato di Zamora viene considerato come un aneddoto della Storia, ma la vicinanza di un altro Paese confinante rende i territori e le province lungo il confine, di fatto, sia portoghesi che spagnoli. Per esempio, gli abitanti dei villaggi spesso attraversano la frontiera per lavorare dall'altro lato. Talvolta, le persone oltrepassano il confine semplicemente per avere una migliore connessione telefonica.

La prima volta che Sofi è venuta a Zamora è stato per lavorare nel settore alberghiero durante l'estate. Aveva lasciato il Portogallo alla ricerca di opportunità. Il posto le è piaciuto talmente tanto che ha deciso di restare. Dopo aver allungato il proprio soggiorno ha incontrato il suo compagno, con cui vive nella periferia di San Vitero, un villaggio di 520 abitanti. Oggi ha un salone da parrucchiera. «Adoro la tranquillità e la pace», dice rapidamente - l’accento lusitano è appena percettibile. Ha studiato amministrazione e gestione aziendale in Portogallo, una competenza che non ha esitato a mettere in pratica, anche per far sì che altri giovani come lei potessero avere l’opportunità di vivere in un villaggio a rischio spopolamento. «Cerchiamo di evitare che i giovani se ne vadano. Tutti pensano che è inutile creare delle aziende perché tra cinque anni qui non ci sarà più nessuno», spiega. Eppure, Sofi crede che molti giovani scambierebbero la città per la campagna se potessero, in modo da avere un equilibrio tra stabilità e qualità della vita: «Visto che la generazione degli ottantenni ci sta lasciando, perché non investiamo nei giovani?». In effetti, ci sono state alcune politiche che sembrerebbero aver funzionato: «Il sindaco è riuscito ad attirare famiglie con bambini per fare in modo che la scuola locale non interrompesse le attività. Con meno di quattro iscritti avrebbe dovuto chiudere i battenti. Fortunatamente, l’iniziativa è andata in porto».
In questa regione che vanta un’ottima produzione di vini, carni, formaggi e funghi, ci sono migliaia di imprenditori con buone idee. «Ma se non ci sono sovvenzioni, perché dovrei comprare quaranta maiali? Non sarei in grado di gestire la mole di lavoro. È così che spariscono i villaggi. D’altra parte ci sono ancora delle aziende, ma sono praticamente “riservate” agli uomini. Anche per questo le donne se ne vanno». La riflessione di Sofi è in linea con quanto raccontato da Rocío ed Emma, da un lato, e le teorie sulla virilizzazione delle aree rurali, dall’altro. La strategia tradizionale prevede che tutti i settori che generano una ricchezza maggiore e che costituiscono il nucleo economico della popolazione, appartengano agli uomini. Le donne, invece, svolgono dei compiti importanti nel quotidiano, ma che non hanno un forte impatto sull'economia locale.
«La generazione degli ottantenni ci sta lasciando, perché non investiamo nei giovani?»
Dalla panca di legno su cui sediamo, si intravede l'orto e, più in là, il paese. Sofi parla in maniera schietta, rapida: è sicura di sé. Passa da un'idea all'altra a un ritmo vertiginoso, ma la sua audacia si trasforma in pudore quando vede apparire una macchina fotografica. Preferisce restare lontana dai riflettori, dal rumore e dal ritmo della città. Tra poco prenderà la sua macchina per andare a vedere degli amici con cui ha piani per il weekend. «Non potrei andare a vivere a Zamora o a Madrid. Per me, è chiaro come il sole», dice, chiedendosi allo stesso tempo cosa ha in serbo per lei un futuro incerto: «Credo sia giusto spiegare alle persone che, tra cinque anni, questa zona sarà spopolata. Se non facciamo nulla a riguardo, sarà un destino inevitabile».

Perché le donne se ne vanno? È da tempo che Margarita Rico, professoressa alla Scuola tecnica superiore d'ingegneria agricola di Palencia (UVa), ed esperta di sviluppo, nonché donna “di campagna”, si pone questa domanda. Anche lei fa parte delle persone che hanno deciso di vivere in un villaggio. Nel suo caso, il paese di turno si trova nella provincia di Palencia. È qui che ha deciso di passare il resto della sua vita: "È il solo modo di vivere che comprendo: la tranquillità, la salute, la qualità dell'aria, il silenzio e, soprattutto, la vita comunitaria", spiega dall'altro capo del telefono. "La modernizzazione della società fa sì che la gente rifiuti l'idea di vivere in un villaggio. I valori predominanti sono il consumismo, l’apparenza, i post sui social network. Quando vado nelle scuole per parlare dello sviluppo rurale molti giovani mi guardano e mi dicono che vogliono abbandonare il proprio paese perché non ci sono centri commerciali. Ma davvero preferiscono un blocco di cemento al benessere della vita di campagna? Non capiscono la ricchezza che hanno tra le mani. Del resto, l’erba del vicino è sempre più verde”. Poi aggiunge: "Le amministrazioni pubbliche sono responsabili dello stato di abbandono perché non sostengono lo sviluppo del mondo rurale”. La ragione è, ancora una volta, presto detta: “Qui non ci sono elettori".
Per amore del vino
A un'ora di macchina direzione sud, a San Vitero, ci aspetta Liliana, 39, originaria delle Asturie. Il paese si chiama Villar del Buey e conta 579 anime. Confinante con il Portogallo, il territorio municipale è integrato nel Parco naturale di Arribes du Duero, una zona in cui le persone in fuga dalla città, possono venire alla ricerca di tranquillità. Il Duero è un fiume accompagnato da vigneti e querceti, che si snoda tra Spagna e Portogallo. La calma e lo scenario bucolico contrastano però con la percezione severa dei residenti: «Una delle cose più difficili con cui convivere è la pressione di chi ti sta intorno. È come se la selezione naturale si fosse invertita: è rimasto solo chi non è potuto partire. Per questo motivo, molte persone ritengono la scelta di tornare a vivere in questa zona ... da pazzi», racconta Liliana mentre ci mostra i suoi vigneti centenari. Le sue figlie, Lola e Vera, corrono dietro al cane tra le piante, e non hanno affatto l'aria annoiata, né sembrano essere sorprese di essere due delle tre bambine che vivono nel villaggio. «Vivremmo forse meglio a Madrid con una tabella di marcia da seguire tutti i giorni, in cambio di un salario?», chiede retorica.

Da donna sposata e madre, Liliana fa il giro del mondo per amore del vino. Ha studiato ingegneria naturalistica a Ávila, ma al momento lavora nel settore vinicolo con suo marito, nei vigneti che appartenevano a suo nonno. Dopo aver vissuto a Madrid per qualche anno, ha percepito gli effetti della crisi e ha ricominciato a studiare. Un'opportunità lavorativa ha condotto lei e suo marito prima in California, poi in Australia. "Negli Stati Uniti ci guardavano perplessi quando raccontavamo che in Spagna le persone abbandonano i vigneti centenari. Oltreoceano, una vigna come questa produce un prodotto da cento dollari a bottiglia. E anche negli altri Paesi europei, sebbene rappresentino la concorrenza, le persone che lavorano nel nostro settore riescono a vendere tutto il vino che producono. Noi (gli spagnoli, ndr.) cediamo litri e litri di vino di ottima qualità a delle cooperative. Questo vino poi finisce in Italia o in Francia dove viene etichettato a dovere. E per chiudere il cerchio, gli italiani e i francesi lo rivendono a noi come se niente fosse". Perchè? "Sanno commerciare meglio", ammette.
Dopo l’esperienza in Australia, Liliana e suo marito, hanno deciso di tornare nella zona di San Vitero e, nel 2015, hanno aperto una loro azienda di vino biologico. Ancora una volta, tutti li hanno presi per pazzi: «Il progetto convince la mia famiglia asturiana, ma chi è di qui, chi ha vissuto la povertà della terra, la miseria e le privazioni, fa fatica a crederci. Qual è la causa di questa depressione collettiva?», domanda al marito. «È come se mancasse l'orgoglio. È un fattore culturale. Il punto è che in questa zona, una volta, la gente moriva letteralmente di fame».
«A tratti siamo felici, a tratti ci chiediamo perché siamo venuti fin qui e perché abbiamo speso tutti i nostri risparmi»
Liliana corrisponde all’ideal tipo descritto dalla professoressa Sampedro: una donna con un livello di educazione medio-alto e con le conoscenze necessarie per gestire una piccola impresa. Liliana sa far tutto: inviare lettere ai clienti, presentare il vino negli hotel di lusso e assumere personale. «È vero che non è facile entrare in questo ambiente rurale senza avere un trampolino famigliare o professionale», spiega. Nel suo caso, il vino è stata la scommessa perfetta, sebbene si rendesse conto delle difficoltà date dal contesto. «Qui, gli unici progetti che vengono messi in piedi sono le centrali nucleari. Durante gli ultimi anni, lo spopolamento è stato intenso ... e poi, in funzione dell’agricoltura, c’è da tenere in considerazione che il suolo è di tipo granitico». Malgrado tutto, l’ottimismo di Liliana è in forte contrasto con la realtà che sperimenta tutti i giorni.
«Nei villaggi spagnoli le persone non sono orgogliose di quello che che hanno. Non penso che sia così anche negli altri Paesi. Per questo, serve un cambio di mentalità», dichiara. Poi attenua i toni: «Sì, è vero che in Spagna, a livello nazionale ci sono problemi da risolvere. Ma abbiamo anche vissuto evoluzioni positive. Il problema è che queste transizioni avvengono a una velocità maggiore di quanto non cambi il nostro modo di pensare. Oggi, per esempio, godiamo di internet e dell'AVE (“Treno ad alta velocità”, in spagnolo): bisogna approfittarne. Economicamente, vivere a Madrid è molto più esigente che stare in campagna. Qui, con un salario modesto vivi bene». Allo stesso tempo, è vero che Liliana e suo marito lavorano in un settore, quello del vino, che non è esattamente in linea con la loro formazione da ingegneri. «A tratti siamo felici, a tratti ci chiediamo perché siamo venuti fin qui e perché abbiamo speso tutti i nostri risparmi. Forse lo abbiamo fatto semplicemente perché amiamo questa dimensione e perché le nostre figlie possano cresce in un ambiente del genere».
Liliana risponde alle nostre domande con l'ottimismo e la mentalità aperta di chi ha potuto studiare quali sono gli elementi necessari per avviare un'azienda in una dimensione di provincia che, per molti, fa rima con noia. Eppure non è tutto rose e fiori. Un po’ come Rocío, Liliana ha scorte di realismo da vendere e non crede che tutti siano fatti per vivere in campagna: «È innegabile che nei paesi come il nostro aleggi molta ansia. Non tutti sopporterebbero un contesto del genere». Ma una volta che si accettano le caratteristiche della vita di campagna, la dimensione rurale offre molta flessibilità: «La gente pensa che quando persone come noi tornano in campagna, queste ultime lo facciano per estraniarsi. Ma non è così! Noi siamo in contatto anche con altri Paesi del mondo. Molti viticoltori portoghesi, francesi, estoni, americani e cinesi vengono a trovarci, interessati al luogo, alla nostra filosofia e modo di lavorare. E tutto questo ci arricchisce enormemente».

Il fatto che le abitudini e i ritmi di lavoro siano diversi da quelli della metropoli non è affatto in contraddizione con l'idea di una “modernità rurale” dove le frontiere, le distanze e le relazioni sono più fluide: «Le differenze sempre meno marcate tra i ragazzi di campagna e di città sono rappresentative di confini sempre più labili tra queste dimensioni geografiche. La scomparsa di queste divisioni contribuisce allo sviluppo di una società "itinerante", nella quale la mobilità costituisce già un elemento essenziale della vita dei cittadini spagnoli. La campagna assiste a un vero e proprio flusso di persone che, a seconda dei casi, vanno e vengono, per lavorare, riposarsi, divertirsi o studiare», sottolinea Sampedro nel suo lavoro accademico, Come essere una persona moderna in campagna.
Nonostante l'ottimismo mostrato da Liliana, Sofi o Rocío, rimane un dubbio: i loro sforzi e la loro dedizione alla causa rurale saranno accompagnati da quelli di altre persone? Difficile dirlo. Ad ogni modo e, forse, senza saperlo, queste donne sono state capaci di mettere in moto piccoli, ma significativi cambiamenti. Hanno iniziato una rivoluzione silenziosa, uno stravolgimento che mostra che non tutto è perduto nella Spagna rurale.
*Gli autori ringraziano Esmeralda, Sonia, Miriam e Nuria per il loro tempo e per aver condiviso le loro storie, anche se non sono quelle citate nel reportage.
Tradotto dalla versione originale spagnola di Ana Valiente e Álvaro García Ruiz per il progetto Empty Europe.
Translated from Zamora : la lutte des femmes contre le dépeuplement by Giulia Bernasconi.