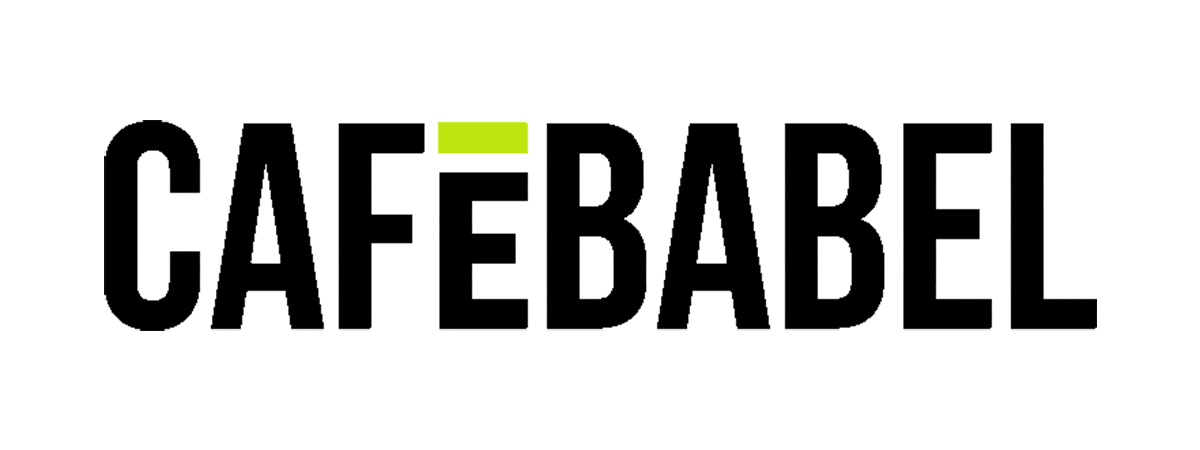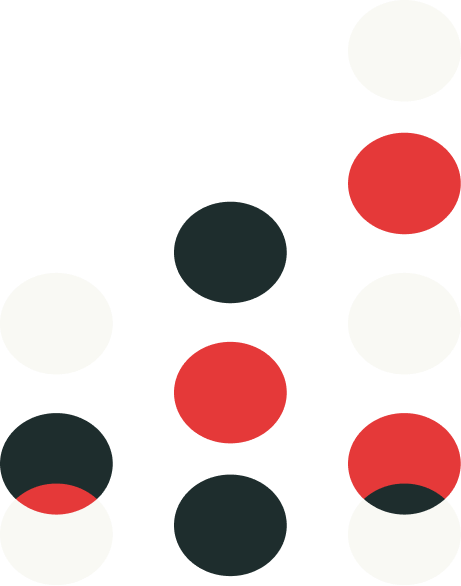Un’Italia orfana di nuove classi dirigenti?
Published on
Articolo di Fabio Oliva La Biennale della Democrazia a Torino
La selezione delle classi dirigenti è un processo delicato e dagli effetti dirompenti per la collettività di un paese. Mancanza di competitività e meritocrazia sono spesso i motivi che impediscono a un paese come l’Italia di produrre una classe dirigente riformista, competente e consapevole del proprio mandato.
La Biennale della Democrazia – organizzata dal 22 al 26 aprile a Torino – ha dedicato un seminario al tema, intitolato “La selezione delle classi dirigenti”, che si è svolto venerdì 23. Hanno partecipato Guido Tabellini, rettore dell’Università Bocconi, Roberto Quaglia e Luca Savarino dell’associazione NEWTO, moderati da Piero Gastaldo della Compagnia di San Paolo. La discussione è stata autoreferenziale e poco aperta agli interventi del pubblico presente al Teatro Gobetti. Il dibattito si è limitato a citare realtà di eccellenza e l’audience non è stata coinvolta come ci si aspettava dall’intento e dal titolo della manifestazione.
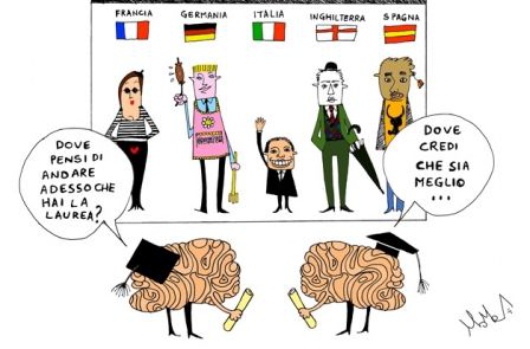 La discussione si è concentrata sulle ragioni del gap generazionale italiano rispetto ad altri paesi europei. Qualcuno ha puntato il dito sulle barriere all’entrata troppo alte, se non addirittura invalicabili. La disparità tra sistema di retribuzione pubblico e quello privato è emersa come uno dei principali motivi per cui tanti giovani talenti scelgono di diventare manager d’azienda piuttosto che dirigenti nelle pubbliche amministrazioni. Altri hanno messo sotto accusa il sistema educativo nazionale, poco competitivo e insufficientemente meritocratico. Fra lo stupore generale, un relatore ha addirittura messo in dubbio l’esistenza di un “caso italiano” parlando di “giovani 50enni” che sono riusciti a raggiungere posizioni dirigenziali di tutto rispetto!
La discussione si è concentrata sulle ragioni del gap generazionale italiano rispetto ad altri paesi europei. Qualcuno ha puntato il dito sulle barriere all’entrata troppo alte, se non addirittura invalicabili. La disparità tra sistema di retribuzione pubblico e quello privato è emersa come uno dei principali motivi per cui tanti giovani talenti scelgono di diventare manager d’azienda piuttosto che dirigenti nelle pubbliche amministrazioni. Altri hanno messo sotto accusa il sistema educativo nazionale, poco competitivo e insufficientemente meritocratico. Fra lo stupore generale, un relatore ha addirittura messo in dubbio l’esistenza di un “caso italiano” parlando di “giovani 50enni” che sono riusciti a raggiungere posizioni dirigenziali di tutto rispetto!
Le (poche) proposte concrete al vaglio
Nel tracciare una sintesi costruttiva dell’incontro, è sicuramente utile mettere in luce le due proposte che sono state lanciate in zona Cesarini. La prima idea è di introdurre un test di ammissione standard – simile allo Scholastic Aptitude Test (SAT) anglosassone – finalizzato a regolare l’accesso alle università e a migliorare l’allocazione dei talenti. La seconda proposta ha posto l’accento sulla necessità di stimolare la mobilità sociale attraverso un sistema di welfare generazionale che offra garanzie e incentivi a favore dei giovani. Una sorta di Erasmus a 360 gradi, non solo rivolto al mondo delle università.
Tuttavia ci si sarebbe aspettati dall’evento un dibattito che non si limitasse a fare i nomi di poche e isolate realtà d’eccellenza italiane, ma che riuscisse a suggerire come innescare un circolo virtuoso su base nazionale e costruire delle economie di scala del talento. Sarebbe bene smettere di parlare in maniera univoca e anacronistica di fuga dei cervelli quando all’estero si esaltano le virtù della circolazione delle conoscenze. Dobbiamo abbandonare lo sterile dibattito incentrato sul ricambio generazionale. Negli Stati Uniti, una delle società più aperte all’innovazione e sensibili al merito, il principio fondante è la continua collaborazione tra generazioni.
La speranza è che per parlarne non si debba aspettare la prossima edizione della Biennale della Democrazia!