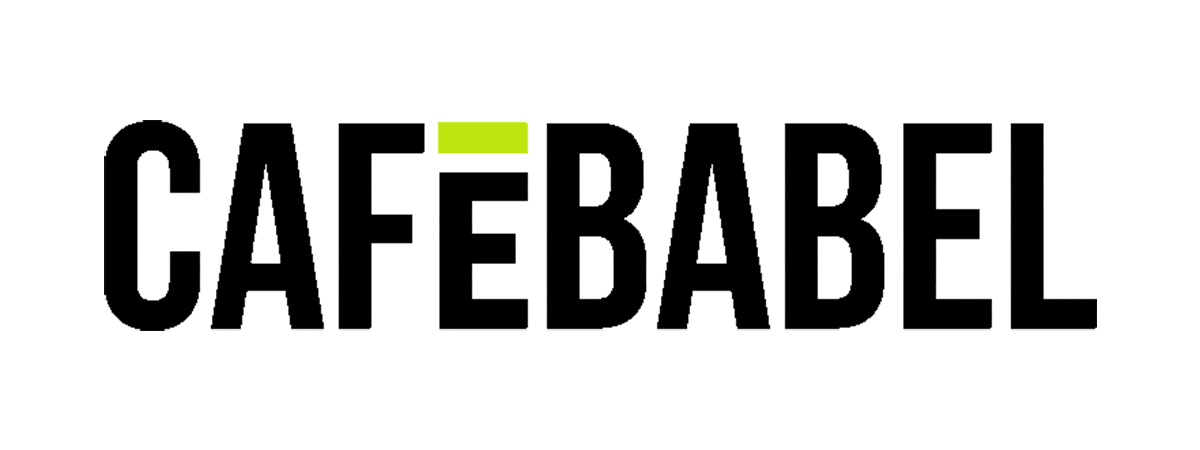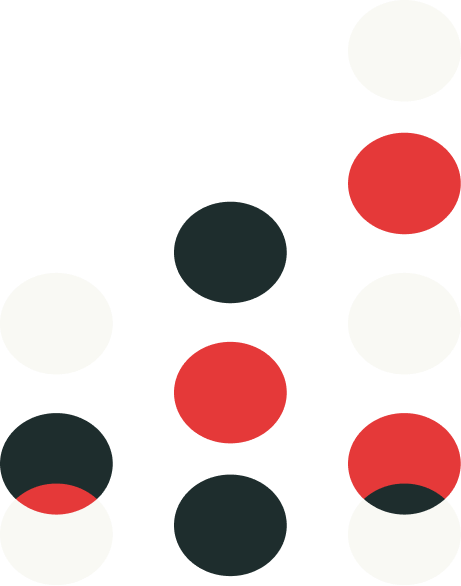Pasolini visto dalla terra: La Rabbia a Sarajevo
Published on
Tra il 1° e il 2 novembre 1975 Pier Paolo Pasolini veniva ucciso. Il poeta friulano diventa un messaggio di pace durante gli Incontri Internazionali della Poesia che si sono tenuti a Sarajevo dal 3 al 5 ottobre 2008. La Ricotta, La terra vista dalla luna e Che cosa sono le nuvole sono stati commentati da poeti venuti da tutto il mondo.
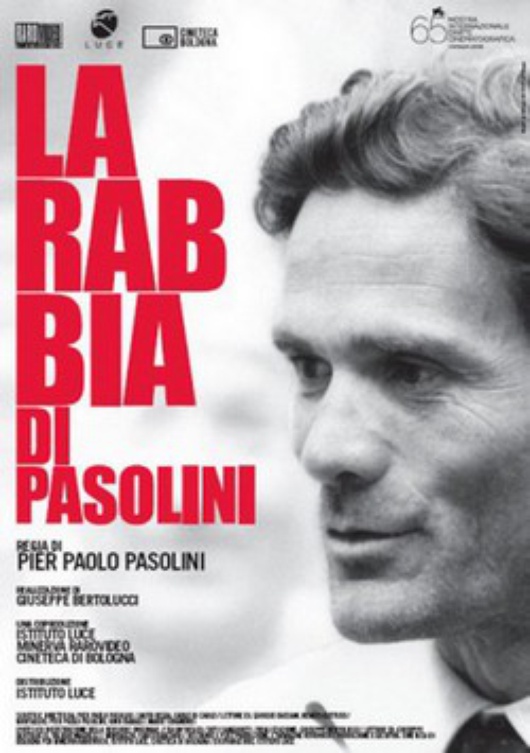 Cento pagine di poesia in Bosnia pesano in marchi quanto un chilo d’oro. E i poeti su carta straniera si rovinano nelle vetrine delle librerie di Sarajevo. Qui dove, superata la parallela della Marsala Tita, quando muovi l'aria con i piedi e passi accanto ai palazzi ancora forati dai proiettili, ti senti piovere in testa la fuliggine della storia. Pier Paolo Pasolini scriveva: «Cos'è successo nel mondo, dopo la guerra e il dopoguerra? La normalità. Già, la normalità. Nello stato di normalità non ci si guarda intorno: tutto privo dell’eccitazione e dell'emozione degli anni di emergenza. L'uomo tende ad addormentarsi nella propria normalità, si dimentica di riflettersi, perde l'abitudine di giudicarsi, non sa più chiedersi chi è. È allora che va creato, artificialmente, lo stato di emergenza: a crearlo ci pensano i poeti. I poeti, questi eterni indignati, questi campioni della rabbia intellettuale, della furia filosofica».
Cento pagine di poesia in Bosnia pesano in marchi quanto un chilo d’oro. E i poeti su carta straniera si rovinano nelle vetrine delle librerie di Sarajevo. Qui dove, superata la parallela della Marsala Tita, quando muovi l'aria con i piedi e passi accanto ai palazzi ancora forati dai proiettili, ti senti piovere in testa la fuliggine della storia. Pier Paolo Pasolini scriveva: «Cos'è successo nel mondo, dopo la guerra e il dopoguerra? La normalità. Già, la normalità. Nello stato di normalità non ci si guarda intorno: tutto privo dell’eccitazione e dell'emozione degli anni di emergenza. L'uomo tende ad addormentarsi nella propria normalità, si dimentica di riflettersi, perde l'abitudine di giudicarsi, non sa più chiedersi chi è. È allora che va creato, artificialmente, lo stato di emergenza: a crearlo ci pensano i poeti. I poeti, questi eterni indignati, questi campioni della rabbia intellettuale, della furia filosofica».
Sarajevo lo scorso ottobre ha ricordato Pasolini, e ha lasciato che ad accoglierne la memoria fossero gli stessi poeti, bosniaci e stranieri. Non esiste, oggi, un’altra città per La Rabbia (testo del poeta friulano che sarebbe dovuto diventare un film e il cui progetto è stato ripreso da Giuseppe Bertolucci) di Pasolini, non esiste un altro luogo che possa spiegarne la necessità. L’indignazione intellettuale della poesia trova a Sarajevo la sua ragion d’essere. Soprattutto se per “La rabbia” dei versi non c’è acquirente e “la normalità” che arriva dopo la guerra è solo una realtà messa tra parentesi.
Sarajevo tra le rovine
Per raggiungere il Kino Teatar “Bosna” – dove gli autori hanno prima visionato i cortometraggi di Pier Paolo Pasolini e tenuto dei reading – il centro della capitale lo attraversi tutto, ed è come se percorressi in ridotto la strada che dalle coste della Croazia (sbarcando a Dubrovnik) porta alle interiora dell’ex Jugoslavia. Da Mostar le case delle battaglie si reggono sulle nuove abitazioni o, forse, le costruzioni post belliche si appoggiano ai ruderi della memoria e nei giardini privati – tra un palazzo e l’altro – gli alberi lasciano scoperti piccoli cimiteri improvvisati. La Sarajevo della Miljacka nasconde con le facciate dei nuovi edifici (amministrativi e commerciali, specialmente) un’intera città che è ancora tutta rovine, la stringe tra le due vie principali, la prima – la Marsala – dal sapore occidentale, la seconda – il lungofiume Obala Kulina Bana – storica e mistica (è su uno dei suoi ponti, “Il ponte dell’attentato” che venne assassinato l’Arciduca Ferdinando). Tutto intorno sono moschee, più o meno recenti, in costruzione.

«Il solo genere letterario ancora in grado di generare un vero dialogo tra culture, tra Oriente ed Occidente, oggi, è la poesia. La cosa che di Sarajevo mi colpisce maggiormente è vedere i minareti e i palazzi europei e i volti umani fusi nel profondo tra di loro», racconta il poeta italiano Giuseppe Conte mentre cammina scrutando un po’ il paesaggio e un po’ le sue scarpe. I volti di cui parla Conte sono tanto quelli di donne avvolte nelle loro pashmine colorate, quanto quelli di ragazze in minigonna e tacchi a spillo, di uomini in cravatta e venditori ambulanti dai tratti turchi. Tutti si passano accanto. Davanti alla grande cattedrale ortodossa della Ferhadija si danno appuntamento gli studenti alla fine delle lezioni pomeridiane. Quando dalla Moschea di Gazi Husrev Beg partono dai megafoni le voci delle preghiere musulmane. E chi è uscito dagli uffici si siede ai tavolini a sorseggiare Coca Cola mettendo via la giacca. Sul tragitto che anticipa il Pasolini de La Ricotta (1963), La terra vista dalla luna (1966) e Che cosa sono le nuvole (1967).
Durante le proiezioni – i film sono stati sottotitolati in bosniaco – Francis Combes (l’intellettuale francese che canta le classi deboli) si stringe il mento con le dita e alla fine si lascia andare ad un’unica frase: «Gènial! Crudo, realista e violento». Ha riso alla battuta di Welles – in La ricotta – sulla borghesia italiana come la più ignorante d’Europa. In fondo alla sala, molto piccola, Rafael Courtoisie (scrittore e poeta uruguaiano) parla di Pier Paolo Pasolini nel suo spagnolo sudamericano: «Uomo viscerale e pazzo», mentre, a titoli di coda spariti, il videoproiettore riprende a girare. Giacomo Scotti (italo croato) conclude: «Al termine dei conflitti diventa compito degli uomini di grande spessore culturale, come Pasolini, riallacciare i nodi spezzati tra le genti».

La strada per il rientro all’Hotel Astra ganj – dove alloggiano i poeti – sembra offrire un’altra immagine di Sarajevo. Le luci delle librerie sulla Marsala restano accese per illuminare le vetrine: si leggono tra i titoli di Pamuk e Coelho anche quelli di Izet Sarajlic (il poeta bosniaco di “La gente è felice quando i versi s’incontrano”). Passando sotto un manifesto elettorale Almir Kolar, giovane poeta, mi indica il volto di un uomo calvo e serio: «Lui è Abdullah, è un famoso poeta e si è candidato alle comunali: centrista, musulmano, nazionalista». Europeista anche, dicono. Pier Paolo Pasolini terminava La Rabbia annunciando l’alternativa alla violenza mondana del sangue, come unica garanzia per la pace perpetua e reale, il «sorriso dell’astronauta» che indichi la via del cosmo. Sarajevo (dei versi e dei poeti) scommette ancora sulle vie della terra.
«Soltanto le grandi borghesie industriali possono suscitare casi di rabbia rilevanti. In Italia no, perché la borghesia è piccola e anche la rabbia contro la borghesia è provinciale, è piccola e limitata. Ecco perché il mio tipo di rabbia non catalogabile si presenta come uno dei pochi tipi di rabbia in Italia. Anche i comunisti rivoluzionari italiani in questo momento sono ancora, tutto sommato, dei borghesi o dei piccoli borghesi in doppio petto che, invece che avere alle loro spalle, per rassicurarli, i dogmi del cattolicesimo e del conformismo borghese hanno i dogmi dell’ideologia marxista». (Da La Rabbia)